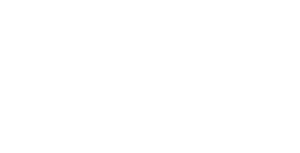MANCANZA DEL CASCO PROTETTIVO E POS IN CANTIERE: RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE

05 Feb 2025
Cassazione Penale, Sez. 3, 10 gennaio 2025, n. 1030 – Ispezione in cantiere.
Mancanza del casco protettivo e del pos
Con sentenza pronunziata in data 21 febbraio 2024, il Tribunale di Campobasso, ritenuta la penale responsabilità di A.A. in ordine ai reati a lui contestati, aventi rispettivamente, ad oggetto, quanto al punto A) della contestazione, la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81 del 2008, per avere omesso, in qualità di datore di lavoro, la fornitura ai propri dipendenti degli strumenti di protezione personale, e, quanto al punto B), la violazione dell’art. 96, comma 1, lettera g) del medesimo testo di legge, per avere omesso, in qualità di datore di lavoro, di presentare il prescritto “piano operativo di sicurezza”, lo ha, pertanto, condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di Euro 3.500,00 di ammenda.
Ha interposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore fiduciario, articolando sei motivi di impugnazione, dei quali i primi quattro rivolti nei confronti della pronunzia relativa alla affermazione della sua responsabilità quanto al reato sub A), i restanti due rivolti verso la condanna avente ad oggetto il secondo reato.
Il motivo sviluppato per primo concerne il fatto che mentre la contestazione è riferita al non avere messo a disposizione dei propri lavoratori gli strumenti di protezione personale (nella specie il casco) la motivazione della sentenza è, invece, sviluppata con riferimento al fatto che l’imputato non avrebbe imposto ai propri dipendenti l’osservanza delle disposizioni relative all’uso dei sistemi di protezione individuale.
Il secondo motivo, connesso al precedente, concerne. Con riferimento alla violazione di legge, la non corrispondenza fra il fatto contestato ed il fatto per il quale è intervenuta la condanna penale.
Il successivo terzo motivo di impugnazione concerne l’omessa valutazione di una prova decisiva, essendo emerso dalla testimonianza resa da un teste dell’accusa che l’imputato, che aveva fornito ai propri lavoratori il casco, era stato sanzionato per non avere preteso che questi lo indossassero, salvo provvedere diversamente non appena gli accertatori avevano riscontrato la circostanza.
Con il successivo quarto motivo di impugnazione è lamentata la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistere la prescrizione relativa all’uso del casco protettivo, sebbene, stante la tipologia di lavorazione edile che era in corso al momento in cui è stato eseguito il controllo, non vi era la necessità di tale presidio poiché non vi era il’ pericolo di caduta di oggetti dall’alto, trattandosi di lavorazione che avveniva a “cielo aperto”.
Il quinto motivo di impugnazione, primo di quelli aventi ad oggetto la imputazione contestata al ricorrente sub 6), concerne la violazione di legge per non avere il Tribunale molisano fatto corretta applicazione degli artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Infine, il sesto ed ultimo motivo di impugnazione riguarda la violazione delle disposizioni codicistiche in materia di prova, avendo omesso il Tribunale di verificare se e quando il “piano operativo di sicurezza” era stato predisposto dall’imputato, accontentandosi di una prova indiziaria, laddove avrebbe potuto agevolmente acquisire una prova diretta dell’avvenuto adempimento da parte del ricorrente degli obblighi a lui prescritti.
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi di impugnazione, stante la loro affinità contenutistica, possono essere esaminati congiuntamente; con essi, sia pure sotto diverse prospettive, il ricorrente si duole del fatto che a lui sia stato contestato un determinato comportamento, cioè non avere fornito ai propri dipendenti taluni dispositivi di sicurezza individuale di cui, trattandosi di persone adibite ai lavori edili, dovevano essere dotati, mentre la sentenza di condanna avrebbe accertato una diversa condotta, cioè non avere vigilato sul fatto che tali dispositivi fossero effettivamente utilizzati dai dipendenti.
Sul punto osserva il Collegio che – sebbene la indicazione normativa presente nel capo di imputazione appaia effettivamente equivoca, posto che, a fronte della segnalazione quale norma violata della lettera f) del comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, disposizione questa che, nel descrivere il precetto, fa esattamente riferimento alla richiesta da parte del datore di lavoro dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizione, fra l’altro, in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale, laddove la descrizione della condotta contestata richiama, invece, il precetto descritto alla lettera d) del citato comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, cioè l’obbligo di fornire i lavoratori dei prescritti dispositivi di protezione individuale – una tale imprecisione, per quanto non commendevole, non è fattore idoneo a minare la legittimità della sentenza impugnata.
Infatti, premesso il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale nel capo di imputazione non è la indicazione delle disposizioni che si assumono violate a costituire l’oggetto della cognizione de giudicante, essendo questo costituito dalla descrizione del fatto che viene contestato, salva la possibilità del giudice di qualificare tale fatto entro la più appropriata fattispecie penale (in tale senso, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 giugno 2023, n. 24365, rv 284670, ove si legge che ciò che rileva, nel capo di imputazione, non è l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto), rileva il Collegio come nella fattispecie dalla lettura della sentenza non emerge il dato lamentato dal ricorrente, cioè che il Tribunale abbia condannato il prevenuto per un fatto diverso da quello a lui effettivamente contestato; vi è semmai da dire che, avendo il Tribunale riferito che la linea difensiva del A.A. era quella di affermare che, data la tipologia di attività che gli operai stavano svolgendo, non vi era la necessità di indossare il casco protettivo, appare distonica l’affermazione difensiva da lui formulata secondo la quale, sebbene ciò non fosse necessario, egli aveva ben provveduto egualmente a dotare i propri dipendenti di tale dispositivo di protezione.
Ad ogni modo l’accertamento operato in sede giudiziale è che i lavoratori non indossavano il casco non essendone dotati; ciò vale ad integrare la fattispecie penale contestata al prevenuto, essendo preciso dovere di questo, nella sua qualità di datore di lavoro, provvedere a tale dotazione.
Discorso analogo vale quanto al terzo motivo di impugnazione, essendo, evidentemente, fattore irrilevante in relazione al di già avvenuto perfezionamento della fattispecie penale in discorso, la circostanza che, successivamente all’avvenuta ispezione degli organi competenti, l’imputato abbia fornito i dispositivi di protezione prima trascurati ed abbia curato che gli stessi fossero indossati; il dato che dall’esame del teste dell’accusa fosse emerso come, invece, i dispositivi erano già stati in precedenza messi a disposizione dei lavoratori dal ricorrente è elemento del quale, onde rivestire della dovuta specificità il proprio ricorso, la difesa dell’imputato avrebbe dovuto trasmettere dati più precisi, essendosi essa limitata ad una affermazione priva di qualsivoglia riscontro.
In ordine al motivo successivo, si osserva che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, l’esecuzione di lavori edili rientra fra le attività che necessitano della predisposizione di un’adeguata protezione del capo del lavoratore, attraverso l’utilizzo di un casco, anche a prescindere dalla circostanza che le opere si svolgano in ambiente chiuso ovvero a “cielo aperto”, atteso che il pericolo che in tale modo si tende a preservare non è solamente quello connesso alla caduta di un grave dall’alto (circostanza che, peraltro, non è da escludersi anche laddove le opere si svolgano a “cielo aperto” ove si immagini la frequente movimentazione di materiali edili e di macchinari attraverso le “gru” impiegate nell’edilizia anche, se non soprattutto, in spazi “aperti”) ma è riferito a qualunque tipo di accidente che la realizzazione di tali opere, in se generalmente fonte di pericoli, può determinare a carico di una parte particolarmente vulnerabile del corpo umano.
Va, peraltro, aggiunto, proprio con riferimento alle lavorazioni a “cielo aperto”, che l’utilizzo di strumenti a protezione del capo è previsto anche in relazione ai rischi connessi alla sua prolungata esposizione ai raggi del Sole.
Venendo ai motivi di impugnazione relativi alla contestazione mossa al prevenuto sub B) del capo di imputazione, è sufficiente rilevare che essi partono da un presupposto errato, cioè che, laddove un determinato fatto quale è appunto la predisposizione e la trasmissione agli organi competenti del piano operativo della sicurezza – possa essere dimostrata con certezza attraverso una produzione documentale, la relativa prova debba essere offerta solo attraverso l’accertamento delle esistenza ovvero della inesistenza di tale documento, e non anche attraverso una dimostrazione di tipo logico-inferenziale (nella occasione data dal fatto che, una volta richiesto dagli Ispettori del lavoro di rammostrare loro il piano in questione l’imputato non era stato in grado di presentare il documento).
Siffatto presupposto, nell’ambito del processo penale – il quale esclude in linea di principio le prove legali ed è, anzi, improntato in termini di libertà dei mezzi di prova e di libero convincimento del giudice nel loro apprezzamento – non trova alcun fondamento sistematico.
Vi è semmai da dire che sarebbe stato possibile proprio al ricorrente – il quale sostiene di avere, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, redatto tempestivamente il predetto piano, e non solo successivamente alla avvenuta visita ispettiva – fornire elementi documentali atti a dimostrare non solo la redazione di esso ma anche il suo inoltro, precedente alla visita ispettiva, agli organi cui lo stesso deve essere trasmesso, non potendo tale prova, evidentemente, essere in maniera efficace fornita, come verificatosi nell’occasione, attraverso la postuma esibizione di un documento la cui data, apposto su di esso ed anteriore alla visita ispettiva, era priva di qualsivoglia certezza.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, visto l’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.